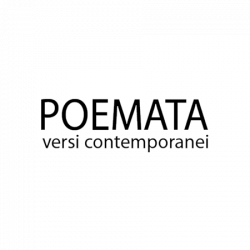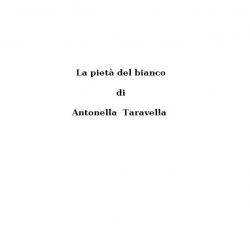Editoriale
di Francesca Del Moro
Ispirandosi ai colori, le poesie qui presentate tendono verso le arti visive: pittura, fotografia, fumetto. I versi melodiosi di Alessandro Silva si fanno pennelli a dipingere di sfumature tenui un cielo piovoso che, attraversato da binari azzurri e da nubi come sbuffi di locomotiva, somiglia alla stazione ferroviaria che sovrasta. Verde, blu, rosso, viola: quattro dei colori dell’arcobaleno compaiono, insieme ad altri, nel sofisticato componimento di Cristina Bove, che segue il ritmo del respiro nella contemplazione di una marina piena di vitalità. Il rosso domina incontrastato nella poesia di Eva Laudace, colto nel fluttuare di chiome di ragazze in corsa, al centro di dipinti di paesaggio che si aprono in sequenza allargandosi fino ad abbracciare il sole e le galassie. Giallo è il colore dei versi malinconici di Rita Stanzione, quello dei margini di vecchi fogli che serbano ricordi, delle luci che tengono accese le passate emozioni. La poesia di Ugo Rapezzi è uno sfrecciare di divertenti giochi linguistici che evocano uno dopo l’altro i sette colori, così da disegnare un improbabile supereroe sotto acidi. Nella quartina di endecasillabi sciolti di Ulisse Fiolo, l’arcobaleno viene infine colto nel suo nascere dall’incontro tra acqua e luce, a incarnare l’indefinibile bellezza della persona amata.
Le bambine dai capelli rossi
di Eva Laudace
Le bambine dai capelli rossi
arrivano da paesi nuvolosi
correndo tra le volpi
e le cerbiatte
carezze dell’estate
o di un fiammifero.
L’aria calda che aprono sul viso
resta aperta
anche sulle teste
sulle bocche dei fiori
sui giochi da grande
la porporina
è un’eterna infanzia
che nuota nelle mani
un’innocenza ballerina
distratta dal colore.
E come soffiano nervose
quando restano da sole
quando avvertono la pioggia
quando perdono le guance
il silenzio è un vento
che si sgonfia piano.
Le bambine dai capelli rossi
non sono gelose delle altre
creature del Nord
brillantine di rame
la bellezza animale
non si addomestica.
Sul collo lattiginoso
sulla coda e sui crinali
tornano intere le galassie
efelidi misteriose
fossero i loro segreti
che ora si vedono
ora diventano più chiare
entrano ed escono maliziose dal sole.
Margini
di Rita Stanzione
Ti sento fiume e arretro piano
sul filo tirato della riva
con la fantasia lavo papiri
di tempo immobile e appagato
Ha margini ispessiti il giallo resina
del non c’è più
dove scorro il passato, apro luci
in qualche crepa di accoglienza
Spettacolore
di Cristina Bove
Lo scenario dipinto verdemare
dall’arenile voci
tinteggiano l’azzurro della trama
un luccichio di vita sulle onde
archi di luce indorano la sabbia
si sta seduti a respirare il sole
si scorgono sirene in amoerro
_il canto ha strani toni di corallo_
invita al sogno
in madreperla e squame
anche se già l’inverno bianconeve
recita il suo monologo d’opale
un tocco di vermiglio
fiorisce di sorrisi e melograni
al termine cadrà sull’orizzonte
il cremisi velluto del telone
un ultimo respiro di viola
_avremo la memoria del tramonto_
ma nasceremo ancora
nella policromia di nuovi amori
Pura
di Ulisse Fiolo
In te c’è una bellezza senza nome:
quella io amo, che per te risplende
come l’arcobaleno – in trasparenza,
all’incontro dell’acqua con la luce.
Allucinando
di Ugo Rapezzi
Dopo il canto del giallo
mi sparai la sostanza arancione
poi via!
Barone rosso in tuta verderame
a bordo di un arcobalenante blubolide
mi lanciai verso l’indaco cielo indiano
trapassai l’elettrico violetto spazio
e scomparvi in uno scoppio di lampo.
Questa pioggia maledetta
di Alessandro Silva
Stazione di Cascina Gobba,
parcheggio scambiatore
è uno sbafo di sole
imbrigliato di bruma
che brilla solo
stamane.
Con l’ultima nube
a vapore che sbuffa
su azzurri binari
di cielo baratto
un mite viaggio
La pietà del bianco
Un oggetto raffinato anche per la consistenza tattile della carta spessa e ruvida, nella quale le parole si incidono minuscole lasciando che il bianco risulti quasi abbagliante. Le pagine tenute insieme da un nastro, anch’esso candido, che è possibile sciogliere, per scomporre e ricomporre la sequenza dei brevi componimenti in partiture sempre nuove. Una silloge, come scrive Alberto Mori nell’introduzione, che ha la durata di una contemplazione. Che può essere vissuta come una sequenza di illuminazioni, o ancora come una pratica di meditazione che ci consente di creare dentro di noi uno spazio sgombro in cui discendere. Lo spazio vuoto delle pagine, che nella concezione ricordano quelle della Serie ospedaliera di Amelia Rosselli, con la quale Antonella Taravella ha in comune la musicalità e un avvolgente senso di mistero. Dal bianco emerge il nero della scrittura e si susseguono i colori, ora nominati, ora semplicemente suggeriti – i petali variopinti evocati dal verbo “fiorire” nella dedica che apre il libro, i verdi, gialli e marroni comunemente associati alle foglie, il giallo dell’urina, il nero delle mani, del corvo e di cerchietti come incubi, il rosso del sangue, del cuore, della bocca, il rosso suggerito dal verbo “incendiare” e il grigio insito nell’aggettivo “plumbeo”. E ancora bianco su bianco, in un ritorno martellante e musicale che fa pensare alle iterazioni del rosso nel Pagliarani del Doppio Trittico di Nandi: il bianco della neve, del piatto, della luce sui muri, delle nuvole… Il bianco è il colore della pietà e del silenzio, del corpo di Cristo, e viene invocato a più riprese con accenti religiosi. In quella che Alberto Mori definisce una “grammatica di gesti”, il corpo vi si abbandona con slancio quasi mistico, attraverso dettagli che affiorano di volta in volta come bassorilievi da un marmo immacolato: le gambine, la boccuccia, la pelle, le guance, l’occhio spalancato che lacrima, la gola, le mani, lo scheletro, le carni, i piedi, l’unghia, la vertebra… Il corpo è al centro di scene oniriche, surreali, spesso inquietanti, che da un lato richiamano il cinema di Buñuel, dall’altro condividono l’estetica dei dramaticules di Samuel Beckett ricordando in particolare l’allucinata confessione di Mouth in Not I. Il corpo avanza nel bianco, come i migranti nel mare di latte in Nuovomondo di Crialese, e il lettore viene inevitabilmente trascinato in questo viaggio.
Antonella Taravella, La pietà del bianco © 2015