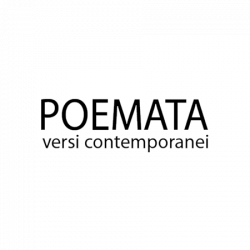Editoriale
di Francesca Del Moro
Raccogliendo il nostro invito, i poeti hanno impugnato i versi come uno specchio rivolgendolo coraggiosamente verso di sé. Svelando al lettore, ma prima di tutto a se stessi, il proprio vero volto. “Più sei personale, e più diventi universale” recita un vecchio adagio ed è proprio così che nasce il gioco di specchi: il coraggio di guardarsi a fondo permette di intravedere la nostra vera sostanza umana, quella che tendiamo a coprire con strati su strati di consuetudine e decenza, ed è in quella stessa sostanza che chi legge sarà portato a riconoscersi. La dolce filastrocca di Roberta Lipparini trasmette un senso amaro: l’immagine di sé come una bambola di pezza rotta da un amore perduto. Con i suoi versi secchi come il colpo della mano sul vetro, Claudia Zironi interroga lo specchio e ne riceve solo la conferma della caducità del bello e dei sentimenti. Ironica e sottile come sempre, Leila Falà trasferisce sulle bottiglie di vetro il proprio desiderio di autodistruzione, portando alla luce la rabbia che si nasconde dietro la propria maschera di equilibrio e profondità. L’ironia sfocia nel sarcasmo nel sonetto di Vincenzo Bagnoli, che osserva la propria parte oscura in un contesto adeguato a esprimere il disgusto di sé. Bello e positivo è invece il sogno a occhi aperti di Giampaolo De Pietro: quello di un’umanità autentica, liberata dalla schiavitù del lavoro e dalla tirannia del tempo.
Il poeta malhereux
di Vincenzo Bagnoli
Cosa guardi quando guardi quel vetro?
cosa vedi che ti guarda nello specchio?
un uomo ogni volta un po’ più vecchio?
la cosa d’altro mondo il mostro tetro?
E cosa senti dentro al tuo orecchio
quando parli, se poi parli a te stesso?
Un suono sconquassato roco e fesso
come la ghiaia scossa in fondo a un secchio?
Ti chiedi qualche volta ancora adesso
che cosa resta riguardando indietro,
ma alle tue spalle c’è sempre quel muro.
E cosa vuoi vedere, chiuso in cesso,
sempre costretto allo spazio di un metro?
Così capirci qualcosa è duro.
bambola bambola
di Roberta Lipparini
bambola bambola
cuore di pezza
bambola vuole una carezza
e piange lacrime di stoffa blu
per quell’amore
che non c’è più
bambola bambola
occhi di vetro
bambola cade
col cuore all’indietro
lo sguardo perso nel cielo blu
a sognare l’amore
che non ha più
passa un angelo che la raccoglie
le dà un bacio
la chiede in moglie
ma il cuore di bambola
è sul pavimento
pianto di stoffa
lo asciugherà il vento
Immortalità
di Claudia Zironi
Allo specchio
ancora una volta
chiedo
Chi è la più bella del reame?
E stavolta con le tue sembianze
risponde, lo scellerato
Sei tu
per il tempo che ci è dato
Sigillo il tempo
con un colpo, secco
di palmo
Gocciola
il rosso a sporcare
l’intatto cristallo
(Il tempo dell’esistenza, Marco Saya ed. 2012)
Fracasso
di Leila Falà
Rumore, fracasso di vetri sbattuti nel rusco.
Piacere di pancia il rumore di notte.
Fracassare con ordine.
Meticolosa rovina.
Bella goduria.
Gran Fracassare senza produzione di danno.
Trenta bottiglie di fila che bello
e nessuno poteva dir niente.
Invece che spataccarmi io contro qualcosa.
Oh be’, gli altri mi giudicano da sempre
profonda ed equilibrata.
Oggi che dal
di Giampaolo De Pietro
Oggi che dal
risveglio non ho
esigenza di
passare per orologi,
sarò forse morto?
O vivo diversamente
libero nel tempo?
Un lavoratore che
non scade?
Un impegnato non
cronico?
Cotone
di Francesca Del Moro
Ci accadiamo lievi
neve dal cielo,
foglie dai rami.
(Una preghiera)
Fresco e lieve è il cotone come le trame di parole e silenzi (spazi e nero d’inchiostro liberamente disposti) che Martina Campi tesse in questo libro, elegante nella sua ruvida copertina bianca e nella veste minimale impreziosita dai disegni di Francesco Balsamo. Brucia facilmente al fuoco lasciando cenere candida, come l’umana esistenza che si affresca in queste pagine. Sul bianco i versi posano colori, come il blu che cuce ricordi, il rosso sbavato dal tramonto sul braccio, il verde che il sole accoglie per sé, il giallo dei fogli e quello che si mischia al buio. Affiorano a poco a poco scene impressioniste o surrealiste, Dalí e Van Gogh. In ambienti a volte onirici a volte pervasi da un realismo sensoriale esaltato dalla pregnanza dei dettagli, a muoversi è un’umanità attraversata da un senso di comunanza, compatta come le fibre del cotone. Ne è testimonianza il frequente ricorso al “noi” o all’equivalente forma impersonale, che di rado lasciano il posto a un io quasi sempre bilanciato dal tu. Un’umanità che, pur costantemente assediata e in qualche modo attirata dalla morte, è viva: ne è prova il respiro, chiamato in causa costantemente al punto che sembrano le pagine stesse a respirare. E sul respiro si modulano i panorami in cui ci si incontra, come dice Martina, gli interni e gli esterni filmati secondo prospettive inusuali, montaggi accurati e lente carrellate: lo sguardo indugia sulle gocce d’acqua, sulle sedie con le giacche, i piedi che “si scusano con i gradini”, le ginocchia che si accalcano nel risalire scale, misura le distanze tra le tende e il divano, si ferma davanti alle superfici di sette colori lasciate dalla pioggia sull’asfalto. Si alternano le stagioni, il caldo e il freddo, la luce e il buio, a voler abbracciare il ciclo stesso dell’esistenza, e in questo ciclo le persone avanzano secondo traiettorie comuni, vivono analoghe esperienze. E sempre tendono l’una verso l’altra con un affetto carezzevole che vibra, anche verso le cose. E ovunque ci sono parole, lasciate davanti alle stufe, pronunciate dal silenzio delle finestre, le stesse parole che sembrano essersi posate sulle pagine come dopo un volo di farfalla. Mentre le anafore, la punteggiatura liberata da ogni regola, gli spazi bianchi e i polisindeti sprigionano una musica dell’accadere che, come avverte Emilio Villa in epigrafe, è piuttosto uno “spalancarsi”.