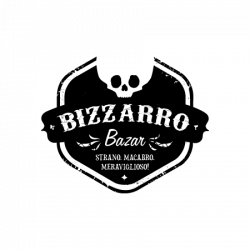All’inizio degli anni ‘30, all’interno del Montreal Neurological Institute, il neurologo canadese Wilder Penfield era alla ricerca di una cura chirurgica per l’epilessia. Le operazioni che si prefiggeva di portare a termine consistevano nell’individuare e in seguito asportare quelle aree del cervello che causavano la malattia, o che ne erano state definitivamente danneggiate. Ma come essere sicuri di come e dove tagliare con precisione?
Per cercare di comprendere più a fondo quali punti fossero sani e quali danneggiati, Penfield decise di operare in anestesia locale. Questo significa che il paziente rimaneva cosciente durante la procedura chirurgica ed era in grado di parlare e rispondere alle domande del dottore, pur essendo scalottato e con il cervello esposto. Questo organo, si sa, è immune al dolore in quanto privo di terminazioni nervose; il dottor Penfield poteva dunque sperimentare senza causare sofferenze inutili.
Toccando il cervello con un elettrodo, e applicando una piccola scossa, il neurologo si “orientava” attraverso le zone sane e quelle disfunzionali, attaccando piccoli pezzetti di carta numerati sulle aree già testate. Ma durante questi esperimenti pre-operatori, successe qualcosa di straordinario.
Mentre operava una casalinga di trentasette anni, Penfield stimolò un punto del suo lobo temporale con l’elettrodo e improvvisamente la donna disse che le sembrava “di essersi vista mentre dava alla luce sua figlia”. A partire da questo primo avvenimento, Penfield per vent’anni toccò con il suo elettrodo centinaia di cervelli: solo una piccola percentuale dei soggetti riportò l’affiorare di ricordi più o meno sepolti, ma abbastanza da convincere il medico che la memoria fosse “una registrazione permanente del nostro flusso di coscienza; una registrazione molto più completa e dettagliata di quella che chiunque può richiamare volontariamente”. Sembrava, cioè, che questo tipo di “ricordo elettrico” (electric recall) riportasse alla luce delle memorie che coscientemente il soggetto non aveva.
I ricordi dei pazienti di Penfield erano molti ed estremamente dettagliati: c’era chi ricordava un ragazzo che strisciava attraverso un buco nella recinzione durante una partita di baseball, chi riviveva l’attimo in cui tirava via un bastone dalla bocca di un cane, o chi di colpo rivedeva la carovana del circo di notte, vista durante l’infanzia.
L’importanza della scoperta di Penfield sembrava assoluta. Davvero la nostra memoria è un enorme hard-disk in cui tutto è registrato e contenuto, e basta conoscere il giusto “indirizzo” per recuperare il file corretto?
Sfortunatamente non è così semplice. Quando Penfield espose il risultato delle sue ricerche negli anni ‘50, la stampa semplificò il tutto con la metafora del registratore, diffondendo l’idea che il cervello memorizzi ogni esperienza con precisa perfezione di dettagli anche se non ne abbiamo coscienza. Quello che i giornali omisero era il fatto che meno del 5 percento dei pazienti di Penfield stimolati con l’elettrodo aveva rivissuto determinati ricordi; per di più, la replicazione dell’esperimento da parte di moderni chirurghi non ha mai portato a simili eclatanti risultati, anche se alcuni ricercatori hanno notato che è possibile provocare brevi allucinazioni attraverso una stimolazione elettrica del cervello. Quindi, dopotutto, forse i pazienti di Penfield non stavano davvero ricordando, ma immaginando.
Oggi sono pochi gli scienziati che ritengono che la nostra mente sia una biblioteca di ricordi inalterati, anche perché diversi studi psicologici suggeriscono che la memoria non è fissa ma viene continuamente reinventata e rielaborata. Un esempio concreto: quando veniva mostrata, all’interno di una serie di fotografie della loro infanzia, una foto ritoccata che li mostrava da bambini all’interno di un Luna Park (in cui in realtà non erano mai stati), la maggior parte dei soggetti si “inventava” una memoria relativa a quel momento fittizio, e raccontava ai ricercatori i dettagli di quella giornata “indimenticabile”.
A quanto pare, come dei provetti registi, modifichiamo nel tempo i nostri ricordi per renderli più consoni alle nostre emozioni, per farli diventare più accettabili o anche soltanto per raccontarli in maniera più interessante agli amici... finendo poi per crederci. Tutto questo getta una strana luce sui testimoni oculari che a distanza di anni nei processi ricordano perfettamente che l’assassino indossava un cappotto grigio macchiato di sangue; ma anche più semplicemente sul nostro stesso passato, così come crediamo di ricordarlo, e in definitiva sulla nostra idea di chi pensiamo di essere.