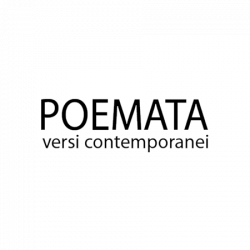Editoriale
di Francesca Del Moro
Alessandro Silva sintetizza splendidamente nei suoi versi raffinati la storia del suo piantatore di alberi facendone quasi un Dio artefice di un paradiso terrestre, fino a chiudere il suo componimento circolarmente con l’acqua che prende il posto dell’iniziale aridità. Alfonso Tramontano Guerritore investiga la personalità del protagonista presentandolo come una sorta di “architetto della natura” visionario, testardo nel perseguire un sogno che a chiunque altro sembrerebbe irrealizzabile. Rita Stanzione fa parlare in prima persona il suo piantatore che si immagina seme, rinascita di natura e architetture vittoriose su crudeli stagioni e terre aride. Nel suo suggestivo componimento, Paolo Polvani assume il punto di vista del viaggiatore che ammira il frutto di tanto lavoro, assecondando l’invito a una fusione con la natura rivoltogli dagli ulivi personificati.
Jona che piantava alberi
di Alessandro Silva
La fonte secca per vento brutale
in quei cinque o quattro rari villaggi
sulle pendici (dove già vivono
male l’egoismo
dell’estate
quei ventimila, in solitudine
di scheletro). L’uomo ne parlò
poco, di pietra ingrassata i vestiti
piedi di acciaio.
Disse veniva
da un ventre di mostro: fittissima
antichità di rapporti in quell’intruglio
di Jona e virtù che nulla poteva
dargli pena.
Gli scese un verme e
róse le erbacce legnose. Fecero
semi i salici e i giunchi, e l’acqua su
tappeti di menta. Fecero feste
campestri i pascoli
di nuovi venuti.
Anche tre giovani intonacate
nude di tutto, per avere pietà
e preghiere a portata di mani.
Sarebbe poi morto quell’uomo
in una goccia del mare.
Gli ulivi
di Paolo Polvani
Guardaci, bisbigliano gli ulivi nella luce
tenue di un crepuscolo, siamo il tuo
respiro.
Guido.
Non mi abbandona un accenno di sorriso,
una piega, un vezzo di stolta beatitudine.
La sera dischiude uno spiraglio. Accendo
i fari. – Siamo il tuo itinerario, il tuo
tormento –. La giacca è reclinata sul sedile.
Si spegne fievolmente una canzone di cui ignoro
ma ripeto e invento e inverto ossessive le parole
che sono una resa e un abbandono.
Noi dimoriamo, dicono gli ulivi, nella
cesura dello sguardo,
siamo un piccolo assaggio, una promessa,
un grido, un soffio, un graffio di felicità.
Da quel nativo verde amore
di Rita Stanzione
Mi vedo sotto questa terra
seme, al piede sterile di ciechi
al sole scuro di un inverno
ansante seme
ai tanti anni di fiume che si asciuga
e mormora qualcosa
di pietre arse.
Ai davanzali
piegatisi a rilento sui dirupi
vi vedo
case di spine
prive dell’ombra di una stagione amata
sapere la povertà d’armi e pani amari
il mietere di raffiche
che non rimettono fruscii, nemmeno una
di foglie da quel nativo verde amore.
Da oggi vi pianto alberi fino alla fine
come orma muta di sopravvivenza
strappata all’acqua dalle sabbie.
Da oggi in poi un diluvio
che non si placa ovunque guardi
davanti al passo
un altro istante di foresta
fisionomia di un ventre che si riempie.
Passerà del tempo
di Alfonso Tramontano Guerritore
Passerà del tempo
di certo non invano
data l’ostinazione
e i fattori naturali
ho un piano
che lascia fare al mondo
la sua legge: io porto i semi
porto la cura che si deve
al desiderio. E la costanza
avrà bisogno soltanto
del percorso dell’acqua
delle stagioni della terra
poi la fabbricazione dei palazzi
di legno vivo, ombra e proporzione
sarà dipesa da me
solo per la forza
di un desiderio
una parte di sogno, poi le foglie
So bene che in quel posto
non c’era quasi niente
non mi credevate ma io
quel bosco enorme
lo vedevo già
La sposa secca del muretto
di Daniela Liviello
“Sarei la sposa secca del muretto / delle foglie canto e vento / sarei la pietra piatta della soglia”: dobbiamo arrivare quasi alla fine della raccolta per trovare qualche indizio sul titolo enigmatico. Si immagina una felce quasi fossile, seccata a ornare un muro di paese. Del resto, dai versi sale di continuo l’anelito a diventare un tutt’uno con il luogo, un paese del sud che, conoscendo le origini dell’autrice, si può collocare nel Salento, ma è al contempo emblema di un mondo a sé che obbedisce a ritmi naturali e umane ritualità. È “lo specchio di un sud più vasto, finestra su un Mediterraneo da sempre travagliato e oggi ancor più dolorante” come si legge nella pagina dei ringraziamenti. È un sud che “non colma distanza” e la sposa lo attraversa a passi lenti, assecondando l’atavica vocazione a legarsi indissolubilmente alla terra. Attraversando le strade familiari, l’autrice ci rende partecipi dei dettagli salienti che incontra, evocando quelle che nell’esergo di Pavese sono chiamate “figure naturali”. Non siamo noi a scegliere di vederle, ma “sanno sorgere” al momento giusto; così il paese a poco a poco si rivela o, per meglio dire, ‘accade’ in un susseguirsi di epifanie. Basta un verso, il più delle volte, o perfino una parola e si innalzano architetture, si aprono piazze e strade, si riuniscono folle, e ancora svettano alberi, si allargano cieli e vividi scorci paesaggistici. Nel frattempo il cammino, scandito a più riprese dal riferimento ai “passi”, prosegue con una certa apprensione. “Affondiamo in acque melmose, / navi in cerca di rotta” avvertono già i primi versi e si continua precisando che il faro è spento, e ovunque è silenzio, tranne che per un breve respiro. È il respiro della terra che vive, una terra in apparenza inospitale, minacciosa e minacciata, in balia del vento, della tempesta, della bufera, ma anche di agenti umani, che vengono ad abbattere e a recintare. Il linguaggio tracima a volte in sequenze verbali che danno corpo al pericolo di aggressioni, squarci, crolli. Serpeggia un senso di paura (ricorrono le parole ‘spavento’ / ‘spaventare’) per la precarietà del luogo e della nostra stessa vita, insidiata anche dalla povertà dei raccolti, dagli incendi che vanificano il lavoro quotidiano. Si avverte il rischio di essere spazzati via, a cui si contrappongono la solidità dell’onnipresente pietra, il peso della terra che resiste, la fatica umana e la regolarità delle feste, delle processioni religiose. E quando ci si sente foglia autunnale in caduta oppure goccia che svapora, ci si afferra alle radici, ai padri e ai santi, che con pazienza e con il lavoro giusto hanno deposto i semi nei solchi, moltiplicato i pani e i pesci. I padri e i santi sono continuità e appartenenza, testimoni di un passato in cui le persone si ritrovavano a discutere nelle piazze, le porte erano tenute aperte per far entrare il fresco in casa e ci si beffava della miseria stando insieme. Oggi questa comunanza ha lasciato il posto a porte sprangate, strapiombi tra le stanze, silenzi. Ci si ritrova solo in processione, a “guardarsi consumare”, mentre si fa strada il timore che un giorno le persone possano diventare indistinguibili dalle pietre con i visi rivolti verso il mare, che possano mutarsi in una distesa di bianche statue come quella profetizzata in uno degli ultimi componimenti. Una previsione favorita dalla lingua, che veicola spesso un’impressione di freddezza e fermezza. Una lingua icastica, a volte tagliente e a volte salmodiante, che si sospende facendoci trattenere il fiato e poi affonda con gli ultimi versi e non di rado con l’ultimo verso isolato, fulmen in clausula. È una lingua scarna che pesa come la terra e riluce come la pietra, intreccia ricami di figure foniche e impunture di parole ricorrenti, riannoda il filo da una poesia alla seguente, unificando i singoli componimenti nel poema coincidente con la totalità della raccolta. È questo il canto nuziale per una terra che non lascia scampo ma che resta capace di una bellezza abbacinante, con l’aria che si inscena tra i rami, l’alba immobile e bellissima, una terra-corpo ricoperta dal velo azzurro del cielo.
Daniela Liviello
La sposa secca del muretto
Edizioni Kurumuny, 2018