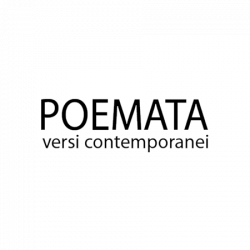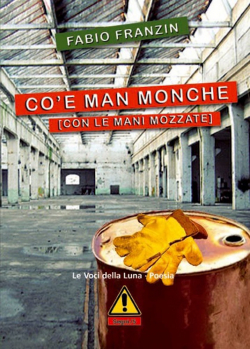Editoriale
di Francesca Del Moro
Una varietà di significati della parola “niente”, per quanto tale espressione possa suonare quasi ossimorica, è quanto emerge dalle poesie selezionate per questo numero. Il breve componimento di Caterina Davinio è una geografica visione del nulla che ci porta in viaggio con lei fino a lasciarci avvolgere da una vastità in cui la natura e gli elementi regnano incontrastati. Nei suoi distici incalzanti, ritmati da pause interne al verso, Daniele Barbieri scandisce le varie tappe di una sorta di nullificazione della scrittura mentre nei versi crudi e ricchi di riferimenti religiosi di Fiorenza Mormile, fin dalle prime ore del mattino un quotidiano “pieno” vuoto di senso prende la forma di un incubo da svegli. Con una sorta di poetica lista della spesa Mariella Tafuto mette a fuoco le mancanze della propria esistenza, arrivando a una conclusione nichilista che però viene ribaltata in positivo nei versi finali mentre l’enigmatica visione di Rita Stanzione esplora un corpo in tensione verso il buio e il dissolvimento, una vita che preme ma si percepisce destinata a svanire. Silvio Perfetti e Rodolfo Cernilogar si soffermano invece su un anacoretico “far niente”, un pacifico esistere e accadere che si ritrova nel piccolo e nell’infinitamente grande, in una castagna così come in Dio.
Co'e man moche
di Fabio Frazin
Come si intuisce dal titolo, le mani sono al centro di questa raccolta in dialetto veneto con versione italiana a fronte, dedicata da Fabio Franzin al mondo del lavoro, un tema a lui particolarmente caro. Le mani sono quelle degli operai, di cui vengono colti lo scoramento e la disperazione conseguenti alla chiusura dello stabilimento. Messi in cassa integrazione o in mobilità, i lavoratori si ritrovano schiacciati dal senso di inutilità, dalle ore vuote a cui non sono abituati. Strumento necessario per guadagnarsi il pane, le mani sono anche lo specchio della loro identità. “Guardateci, guardateci, guardatemi” ripete Franzin mentre lascia affiorare un barlume di coscienza di classe mostrando uniti nella sventura gli stessi colleghi che prima erano pronti ad azzuffarsi tra loro o a ingraziarsi i superiori a danno dei propri pari.
Ma per adesso non si scorge alcuna scintilla di ribellione in questi uomini, per quanto la TV rimandi immagini di proteste e manifestazioni. Piangono, battono la testa contro il muro, bestemmiano, ma restano remissivi come sono sempre stati: li seguiamo mentre vagano per le strade del paese, le spalle gravate dalla vergogna verso la famiglia che non sanno più come mantenere. Esitano all’idea di rifugiarsi in un bar in fuga dal freddo, perché qualunque cosa, che sia un caffè o un bicchiere di vino, ha un prezzo che non possono più permettersi di pagare. Qualcuno si ferma a guardare una felpa rossa in vetrina, riconoscendo l’atto del questuante nella mano tesa del manichino, e acquista l’articolo come forma di consolazione. Sono anch’essi questuanti che di fabbrica in fabbrica chiedono in elemosina un nuovo lavoro, finché la speranza svanisce e subentra la malattia. Alcuni vengono sopraffatti dalla depressione, altri sviluppano un eczema sulle mani per il fatto che ormai le tengono “inchiodate nel vuoto”.
E ancora sulle proprie mani infierisce Carlo, che non lavora da sei mesi, in una delle giornate senza fine trascorse a ciondolare in casa, ormai sbrigate le faccende domestiche, quando a fargli compagnia resta solo la televisione con i suoi squallidi programmi. Si stuzzica i calli con l’unghia, li stacca coi denti. Dalle mani “pencolano stigmate fasulle” perché la crisi ha trasformato tutti questi uomini in poveri cristi, come accade al caporeparto che si sentiva un re e adesso porta la corona di spine dei propri pensieri, subendo il calvario a cinquant’anni piuttosto che a trentatré. Il tema religioso è un filo rosso che attraversa tutto il libro: il miracolo economico del Nord-est è compiuto da un santo in processione che fin dai primi versi appare nell’atto di andarsene, mentre la grandine sferza la fabbrica e la nebbia avvolge il reticolo di paesi. Così la natura si vendica idealmente delle strutture artificiali che l’hanno spodestata, e alla fine “non c’è più uva né lavoro”. Quello del paesaggio è un altro dei temi prediletti dall’autore e qui ritorna, nel conflitto tra scenari naturali e artificiali, a scandire il passaggio tra la presa di potere e la successiva sconfitta dell’industrializzazione. Vi è un’insistenza sui materiali, su ogni genere di arnese, che ci porta a comprendere i gesti sapienti e la fatica fisica dei lavoratori, ad assorbire il loro senso di impotenza in mezzo agli strumenti adoperati per tanti anni. Dettagli vividi che alla fine scompaiono nel bianco. Quello delle notti in bianco, della biancheria che svolazza appesa al filo con le camicie che brandiscono i polsini come fantasmi, in tutto somiglianti agli ex operai che è come se avessero perduto le proprie mani, “non più richieste da nessuno”. Mentre, come un bianco lenzuolo funebre, la neve ricopre la fabbrica, ricopre il sogno di Smirald, che sedici anni prima è arrivato dall’Albania, il sogno dei padri di famiglia di estinguere il mutuo, di far studiare i figli. Una poesia, quella di Fabio Franzin, piena di bellezza, di umanità, che stringe il cuore e al tempo stesso è politicamente dirompente.
Fabio Franzin
Co'e man monche
[Con le mani mozzate]
Le voci della Luna, 2011
Senza titolo
di Caterina Davinio
Campi aperti
dove soffia il nulla
in scorribande di vento,
danze di polvere,
sudore
e insetti,
erbe secche avviluppano
e minacciano con loro dita sottili
graffianti,
e luce che ferisce,
gli occhi, la ragione.
da Aspettando la fine del mondo, Fermenti
Senza parole
di Daniele Barbieri
voglio scrivere poesie senza parole, voglio sciogliere
versi nell’aceto, versi nel fango, voglio parlare
senza aver nulla da dire, frasi magnificamente
vuote, nuove, sole, nere o piene di silenzi grafici,
piene di vuoto, voglio scrivere poesie di cui sia
sottratto il senso, senza
valore di verità, senza responsabilità,
versi d’aceto, versioni vanagloriose del vento
Hornbeam - Esaurimento
di Fiorenza Mormile
Sentieri d’odio corre l’anima al mattino
mentre ancora sdraiata sul letto
già sanguina la fronte per le spine
d’incombenze di cui si è perso il senso.
Poi c’è lo strappo: gli argani invincibili
della Routine, signora di ogni cosa,
drizzano la croce svertebrata:
(reggerà, pure per oggi, il peso?)
Permane ancora l’involucro del rito,
ma senza più riscatto per nessuno.
in Variazioni sul Lausberg, DARS Edizioni, Udine, 2003
Non ho
di Mariella Tafuto
- preghiere da recitare la sera
- un corpo da stringere nel letto
- il tuo sesso tra le gambe
- un’altra vita possibile
- buongiorno e un sorriso
- smettila, ti faccio il solletico!
- fammi un bacio con la lingua
- una mano sul tuo culo nudo
- cambiali in scadenza
- bilanci da mettere in pareggio
- un male curabile
- l’ufficiale giudiziario alla porta
- buonanotte e sogni d’oro
Non ho che me e un giocattolo
che non serve a nessuno.
Così mi basto.
(quel che non ho, basta e avanza)
Il nero è questo spolverino
di Rita Stanzione
Il nero è questo spolverino
a forma umana
che preme, sfiora le ossa,
i fiori sbagliati in un unico stelo
arrendevole alla più muta carezza.
Rieccola la vita
è una colpa sul filo. Tuttora
spinge da un capo all’altro
nel mancarsi da vene senza promesse.
Principia col niente dei pori
e fragranze ammucchiate
nel tramonto, è il sonno che scioglie
le immagini portando l’occhio
cucito su un pezzo di buio.