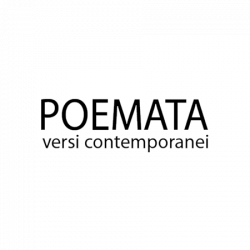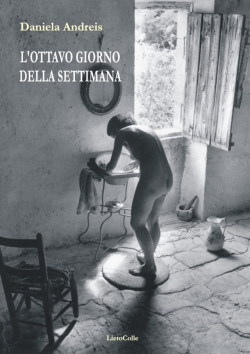Editoriale
di Francesca Del Moro
Quando si pensa a un cieco, si immagina qualcuno che ha perso la vista e trattiene nella mente l’immagine un tempo esperita del mondo. Come il protagonista dei versi di Emanuele Patrizi, che ora può distinguere solo al tatto il bianco e nero dei tasti di un pianoforte, come la persona che nella poesia di Armio Neloci subisce una metamorfosi che la porta a coincidere con la sua malattia. Ma la cecità è anche l’“antisguardo” di chi non avendo mai conosciuto la realtà con gli occhi la rifonda, come insegna Fiorenza Mormile coniugando sapientemente logica e visione poetica. Spostandosi verso il piano metaforico, i versi incalzanti di Daniele Barbieri mimano un vortice che a poco a poco trascina verso un nero fondo dall’attraente e pericolosa luminescenza, mentre il brevissimo componimento di Veruska Melappioni concentra nel sorgere di un’alba le dicotomie inizio/fine, notte/giorno, buio/luce.
Luminescente
di Daniele Barbieri
a scendere vasca dopo vasca verso il lago, verso
l’entità luminescente che sta in fondo, così vasta
che c’è qualcosa in eccesso, sempre, nel chiarore che
stabilmente ne traspare, sempre, verso l’entità
luminescente che è il lago, così vasta che l’eccesso
del suo chiarore traspare, che la luce grida, che
ci dimentichiamo in questa gloria che la superficie
non vive la stessa vita di quello che le sta sotto
con la sua nota blu, ferma e poi sempre e sempre più
ferma nella nota nera, quella del buio del fondo,
quella dei morti del fondo, quelli che la luce getta
dentro il compatto sparire a vasca a vasca nel lago,
nel fondo dell’entità luminescente, buio a buio,
freddo e alieno, morte a morte, nel trattenere il respiro
che ascenderebbe a gorgogli, frusciante sotto la pelle
fredda, contro il suo silenzio, contro il silenzio dell’acqua
nera, contro il nero pieno del sangue freddo del fondo
Ora i tasti del pianoforte sono tutti neri
di Emanuele Patrizi
Ora i tasti del pianoforte sono tutti neri
devo toccarli per vederli,
per distinguere i diesis dai bemolli.
Il suono si mescola ai colori
posso distinguere le quattro dimensioni.
Ma quale mela del peccato quella mela è marcia
mi hanno lasciato al buio rubandomi la torcia.
Questo inizio finirà
di Veruska Melappioni
Questo inizio finirà.
Coda del manto,
alba di San Silvestro.
Quando divento la mia malattia
di Armio Neloci
Quando divento la mia malattia
parlo il braille di tutti i miei nei,
mi incurvo poi, mi si piega la schiena
come un blister nella spina dorsale,
infinitesimale:
sono un numero in fila
di una serie infinita
di una sequenza dopo la virgola.
Ipotesi sulla cecità
di Fiorenza Mormile
Se immagino il mondo dei ciechi
lo faccio sempre partendo dalla vista
da chi l’ha avuta e a un tratto non l’ha più
ma continua a figurarsi il mondo
ad occhi chiusi, come nei sogni,
o come nella mente di chi ascolta
le favole alla radio.
Forse chi nasce cieco è più creativo,
non rispecchia il mondo, lo rifonda,
ha parametri aperti, un “antisguardo”
e modula declinazioni infinite,
non buie, diversamente colorate.
(in Da Elsa a Isabella, Quaderno del Dars n. 12, Udine, 2017)
L'ottavo giorno della settimana
di Daniela Andreis
L’ottavo giorno della settimana è un tempo immaginato fuori dal tempo. Si accorda ai mesi, alle stagioni, alle ore ma è il giorno in cui è possibile “correre dalla parte opposta della gara”, il giorno in cui si è liberi da ogni obbligo, pressione, attività, e ci si può ritrovare nel ricordo e nel sogno. Due dimensioni che si compenetrano nei versi di Daniela Andreis, popolati di amate presenze, che affiorano a poco a poco, definendosi attraverso piccoli dettagli: i gesti, gli atteggiamenti, gli oggetti familiari e gli accadimenti che hanno segnato la loro vita. Le loro storie si profilano in un lampeggiare di interni in osmosi con la natura, in sequenze di istanti imbevuti di pensieri e desideri. Gli occhiali, l’orologio, l’acquasantiera, il legno, i fiori di menta, la traccia di un gelsomino sul muro: tutto è osservato e raccontato con uno sguardo che dell’infanzia trattiene la capacità di attenzione ed è pronto a consegnarsi allo stupore. Si respira in queste pagine un’atmosfera da casa antica di campagna, dove ogni cosa è preziosa e conserva la storia di due persone che è dato riconoscere come il padre e la madre dell’autrice: un gigante e una donna di scheletro piccolo che farà di lui “un fiore innamorato di una corolla minuscola”. Il loro amore scivola nei versi, dai primi slanci fino all’addio, e si intreccia al rapporto tra le figlie, alle passioni dell’autrice da adulta. Perché il sogno e il ricordo non sono segmentabili in compartimenti stagni, e l’amore “che prende tanto posto da impedire di respirare” vi fluisce libero, tendendosi verso tu mutevoli, con un linguaggio che si sbarazza di ogni logica lineare per appagare i sensi, vivere di musica e metafore. L’ottavo giorno è il giorno in cui si può amare “a ritroso”, si può “far tornare indietro il cosmo, retrocedere il perno del sole”. È un giorno in cui si diventa clessidre che perdono i grani lentamente, che si rovesciano secondo il proprio ritmo più autentico. È il giorno eccedente in cui si celebrano le nozze degli amanti clandestini, il giorno inventato come l’amore. “Non è facile parlare ai viventi” recita uno dei brevissimi componimenti che, spesso riducendosi a un solo verso gnomico, scandiscono il libro a suggerire chiavi di lettura. Per questo della “mola della parola” l’autrice fa una dimora altra, in cui può davvero parlare con le persone amate, forgiando una lingua in grado di esprimere, nell’ottavo giorno della settimana, “l’amore inenarrabile” di Mandel’stam, in grado di rivolgere al padre, alla madre, alla sorella, agli amanti, il suo “appello all’amore impronunciabile”.
Daniela Andreis
L'ottavo giorno della settimana
Lieticolle, 2017