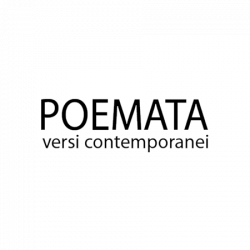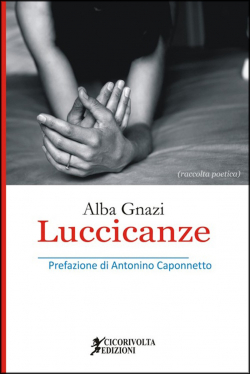Editoriale
di Francesca Del Moro
I poeti qui presentati sono stati invitati a ripensare secondo la propria prospettiva – laica o religiosa – un doppio numero sette fondamentale per la Chiesa Cattolica: la contrapposizione tra vizi e virtù. Scegliendo di trattare una delle quattro virtù cardinali nella sua versione meno nota, ovvero il coraggio in luogo della fortezza, Raffaele Ferrario ci mette a parte di un colloquio interiore che annoda e scioglie dubbi spalancando vivide visioni, mentre una particolare chiave di lettura viene suggerita dalla dedica, una possibile allusione all’eroina francese che di grande coraggio diede prova nella vita e in punto di morte. Usando la religione come metafora per un tema politico, i versi fluidi e pregnanti di Alessandro Silva prefigurano un’Apocalisse che pone fine a un’umanità perduta, inghiottita tra cenere e cemento e aggrappata a una fede fatta solo di parole e ormai incapace di salvarla. Attraverso una fitta trama di rispondenze sonore, la poesia di Giovanna Olivari mette in scena un dialogo acceso e divertente sul tema dell’accidia, senza trascurare riferimenti letterari e religiosi come nella chiusa particolarmente felice. Sarcastica e graffiante, Eleonora Tarabella frulla insieme le sette virtù e gioca sapientemente con la lingua per far saltare la dottrina cattolica e al tempo stesso colpire al cuore l’ipocrisia della Chiesa.
Il coraggio
di Raffaele Ferrario
che cos’è il coraggio
è il raggio espanso del cuore
quando l’ago del sole
illumina i golfi e la luna
in pienezza si adagia
sull’onda del mare
quando la sabbia fluisce
dentro l’agio del dubbio
e la luce lava via il disagio
sotto la superficie
di ciò che diviene perfetto
nel coraggio si celebra
il matrimonio a se stessi
e si è testimoni di gloria
che il vento assapora
e il rigore comprende
ma il coraggio
che cosa risponde il coraggio
alla domanda chi sei
nulla di che
il vuoto soltanto
in cui l’essere vibra
per abbondanza di come
invece di perdersi
nell’ego di perché infiniti
tanto curiosi quanto delusi
restare minimi nella grandezza
questo è coraggio
che dal vuoto raccoglie
se stesso e nel vuoto
sperimenta la gioia
di mettersi a fuoco
quando la fiamma
penetra il coltello
e incuora con forza
la porosità del metallo
nel punto dinamico
in cui s’irradia l’incontro
dal nucleo direzionale
al culmine della coscienza
dove il respiro è di casa
e la morte un’opinione
ci vuole coraggio
scorrendo fra regno e corona
col favore della misericordia
la bellezza oltre il fondamento
come sorgente d’acqua verticale
in cui bere la conoscenza
non servono i muscoli
ma il corpo all’unisono
ed è il moto del cuore
che tende a legare
con la propria intelligenza
coraggio
il coro che il cuore dirige
con maestosa sapienza
l’organo sconfinato
dei nostri talenti
fatti a vittoria
senza la parola fine
Accidia
di Giovanna Olivari
La tua accidia m’acceca
m’uccide m’avvince
mi cinge mi stringe
lenisce – dicevi – le mie
ulcere da stress.
L’ozio – dicevi – è
rivoluzionario.
Non il tuo.
L’accidia illude
e tradisce.
Quell’indolenza, quella tua assenza
di desiderio per alcunché,
per chicchessia, pure per te
t’hanno isolato, esiliato.
Pietrificato la vacuità.
Piuma di marmo
alla pioggia e al sole.
Gigante tra lillipuziani
con le tue mani
interminabili fili
hai annodato
la tua rete la tua prigione
inesorabile.
Io non sarò con te
nella palude Stigia.
Non mi volterò
quando m’invocherai
con il dolce flauto dell’ozio.
Non diverrò statua di sale.
Io
non mi volterò.
Prude forte giù
di Eleonora Tarabella
Prude forte giù,
oh, quanto mi prude!
Avrò pur mangiato del tiramisù!
La gola, si sa,
prende già a colazione...
Magari sarà troppa fornicazione!
Se penso alle tre gettonate virtù
- chi visse sperando morì ca--rdinale -
con carità e fede si sanno di più
e col catechismo le impari non male.
Ma le teologali...
Prude forte giù:
prude-nza, for-tezza, te-mperanza, giu-stizia...
Le impari a memoria col tiramisù:
come con le Alpi,
ripeti anche tu.
Bambini innocenti,
banche e appartamenti
chi predica bene
trasforma in virtù.
Io invece continuo,
se mai a fornicare,
con chi, per età,
può recarsi a comprare
un tiramisù. Non la casa
ché quella se l’è già cuccata quel tal cardinale
che certo dimostra, senz’altri pruriti,
che “ipocrisia” è un’altra virtù teologale.
Rosa di fede
di Alessandro Silva
Si è alla fine del mondo tra i suoi alberi
di cenere e le raffiche di inverno.
Una misura di frumento resta
tutto il becchime concesso agli uccelli.
Tre misure alte di orzo vanno agli angeli
assassini. Loro hanno fuoco e ali
ma anche due mani fatte per le spade.
Strisciavi ieri nel tuo eden e li hai visti.
Dell’età per salvarti rimane ormai
orfana la bocca, appassita rosa
di fede. È stupore nei minuti
di uscita sul cemento, dalle fabbriche.
Luccicanze
di Alba Gnazi
“Stavo per scrivere innocue, ma la poesia di rado lo è. Non lo è mai, in effetti” si legge, a firma dell’autrice, sul retro di copertina del libro di Alba Gnazi, Luccicanze. Una dichiarazione di poetica forte e precisa, che rivendica per la scrittura il coraggio di far male, a se stessi e agli altri, conseguenza inevitabile del mettersi a nudo e per proprio tramite fare lo stesso con chi legge. L’inevitabile associazione con il celebre film di Kubrick fa pensare a una sensibilità speciale e, come quella di Danny, tutt’altro che innocua, che al poeta dona la benedizione/maledizione di scovare le tracce nascoste nella realtà. Tracce che, scrive Alba, sono come “le pietre scartate dal mare”, gemme inaspettate che brillano di acqua e sole “in filo d’ombra”. Il libro, come spiega l’autrice in una nota inserita a guisa di prefazione, si compone di poesie scritte nell’arco di cinque anni, legate da un filo comune che coincide con “la mano che scrive”. Ciò sembra suggerire una certa eterogeneità, che però viene felicemente superata da una grande coerenza stilistica. Estesi e immaginifici, i componimenti funzionano come partiture musicali scandite da accorgimenti ricorrenti quali incalzanti ripetizioni, allitterazioni e assonanze, anacoluti e sospensioni, e un ritmo sempre curatissimo che ora sembra prendere il volo in direzione della canzone, ora si modula sugli slanci emotivi, sull’ansimare o sul placarsi del respiro. Particolarmente curate sono le chiuse, specie quando il ritmo rallenta come musica che sfuma o luce che gradualmente si spegne. La musica così presente sforza i molteplici contenuti in direzione di un’intensificazione, come se a muovere i versi fosse il desiderio di penetrare a fondo nella vita, succhiarla come si fa con la luna in uno dei bellissimi componimenti a lei dedicati o viceversa lasciarsi penetrare fin nelle ossa (la luna e le ossa sono tra le presenze ricorrenti che danno uniformità alla raccolta). Senza porsi alcun limite, i versi assorbono il racconto in prosa, la cronaca, il dialogo teatrale, la sequenza cinematografica, senza mai perdere ritmo e densità così da restare sempre, e in tutto e per tutto, poesia. Sulla quale ci si interroga senza sosta cercando, come si chiarisce in “Non ho voglia di scrivere poesie”, di spingere la parola oltre ogni limite, fino ad ammantarla di un valore soprannaturale. Influenzata dalla letteratura inglese, e in particolare dall’amato T.S. Eliot e da Sylvia Plath, a cui viene dedicata una poesia-canzone, l’autrice non esita a utilizzare la loro lingua, ma anche il dialetto, per rendere ancora più espressivi i suoi versi. I temi sono tutti i temi della vita: l’amore, a volte sfiorato a volte vissuto con passione, il rapporto madre-figli che si declina attraverso esperienze e punti di vista molteplici, i ricordi che affiorano portando con sé spazi interni ed esterni e figure, principalmente femminili, evocate con affetto e attenzione ai dettagli, i fatti di cronaca e il loro premere sulla coscienza fino all’immedesimazione. Un libro ricchissimo, complesso e appassionato che, pur essendo un’opera prima, dà prova di grande maestria e spalanca nuove e promettenti prospettive.