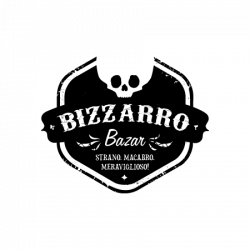Ogni città ha le sue celebrità locali. Roma aveva Mastro Titta.
Giovanni Battista Bugatti era nato intorno al 1779 e di professione verniciava ombrelli. Viveva a Borgo Sant’Angelo, al di là del Tevere, e per la sua sicurezza personale era costretto a rimanervi sempre: se avesse mostrato il suo volto per le vie della città, l’avrebbero certamente fatto a pezzi. Così se ne stava tranquillo, al sicuro nel domicilio coatto in vicolo del Campanile, fino a quando non erano richiesti i suoi servigi. Allora, smessi gli umili panni di ombrellaio, come i moderni supereroi il Bugatti indossava un mantello scarlatto e si trasformava nel suo straordinario e temuto alter ego: Mastro Titta. In chiesa genuflesso si confessava, prendeva la comunione, e poi in pompa magna si decideva ad attraversare il fiume. “Mastro Titta passa ponte!” si gridava in tutta Roma: indizio che lo spettacolo stava per cominciare.
Vera leggenda vivente, Mastro Titta non sbagliava mai. Che usasse il maglio, l’ascia o le corde, la sua abilità era sopraffina: conduceva il condannato sul suo palcoscenico finale, sotto gli occhi della folla assiepata a Piazza del Popolo, e gli offriva talvolta una presa di tabacco come ultimo conforto terreno. Poi, a seconda della sentenza decretata dal Papa, il boia pontificio si metteva all’opera. Impiccava, strangolava, decapitava, bruciava. La mazzolatura e lo squarto richiedevano forza e precisione: Mastro Titta fracassava la testa del colpevole con un colpo di martello ben assestato, poi tagliava il corpo a pezzi e li affiggeva agli angoli del patibolo mentre, fra il pubblico, i genitori costringevano i bambini a guardare per bene. Che imparassero come si finisce a seguire brutte strade.
In sessantotto anni di attività, Mastro Titta eseguì 516 “giustizie”, tutte portate a termine in maniera esemplare, da “carnefice modello, e artista veramente degno del teatro nel quale era chiamato ad agire”, come lo definirà lo scrittore fiorentino Alessandro Ademollo. Perfino quando dalla Francia napoleonica arrivò l’ultimo ritrovato della tecnologia, questo “nuovo edifizio per il taglio della testa” di cui si faceva un gran parlare, ovvero la ghigliottina, Mastro Titta dimostrò di saperlo maneggiare alla perfezione. In soli quattro anni, dal 1810 al 1813, nel cesto caddero 56 teste. Tutte rigorosamente annotate da Bugatti sul suo taccuino, dove aveva segnato ogni incarico fin dall’inizio della carriera, indicando date, nomi, colpe, il compenso ricevuto e i bonus guadagnati di tanto in tanto, quando l’esecuzione era stata così stupefacente da suscitare l’ammirazione del Papa o dei vescovi.
Il 1° novembre del 1864, “er Boja de Roma” si ritirò finalmente dalle scene, con una pensione mensile garantita di 30 scudi a ricompensa dei lunghissimi anni di servigi senza macchia. Era così famoso che dopo di lui ogni carnefice verrà chiamato invariabilmente Mastro Titta. Morì nel 1869, alla veneranda età di 90 anni.
Ma la sua figura entrò in modo duraturo nel mito della città, dalla letteratura al folklore, dai sonetti del Belli alle filastrocche per bambini: Sega, sega, Mastro Titta / ’na pagnotta e ’na sarciccia / un’a mme, un’atte / un’a mmàmmeta che sso’ ttre.
Di lui scrissero Lord Byron e Charles Dickens, che erano stati spettatori di alcune sue esecuzioni, e il folklore romano lo celebrerà in infinite varianti, fino ad arrivare alle commedie musicali con Aldo Fabrizi e al cinema di Luigi Magni.
La celebre tonaca scarlatta di Mastro Titta, insieme all’ascia e ad alcune ghigliottine, si può ancora ammirare al Museo Criminologico di Roma.