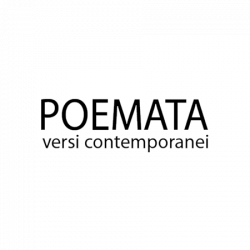Editoriale
di Francesca Del Moro
“Nella foresta vive un mostro
e mi assomiglia moltissimo”.
PJ Harvey
Nella sua accezione negativa, la parola “mostro” indica un essere reale o immaginario che presenta deformità fisiche o tiene un comportamento radicalmente amorale. In questo secondo senso, il mostro è visto spesso come l’incarnazione della malvagità umana in generale o come la parte di noi con cui facciamo fatica a venire a patti, sia essa oscura e pericolosa oppure fallimentare o disgustosa. Ma il mostro è anche il bersaglio designato da società che hanno bisogno di compattarsi contro un nemico che appaghi la morbosa curiosità delle persone, soddisfi il loro desiderio di sentirsi migliori, offra uno sbocco alla loro frustrazione. La filastrocca di Silvio Perfetti ci introduce nella psiche di un assassino portando alla luce un umanissimo conflitto in cui è facile immedesimarsi, mentre nella poesia di Vera D’Atri la donna oppressa e deformata dalle molteplici incombenze si trasforma in una grottesca divinità. Di grande efficacia visiva è anche il mostro disegnato con rapidi tocchi da Ugo Rapezzi: l’uomo nuovo perennemente collegato a una macchina che gli succhia via ogni traccia di pensiero. Infine, il mostro in cui si specchia Valentina Gaglione è un fragile individuo rimasto ai margini di una società che gli instilla rabbia e lo addita come un nemico.
Il mostro è l’opposto
di Valentina Gaglione
La paura di vivere
è un mostro stanco
ogni centimetro d’astrazione
è fetta d’indicibile solitudine.
Tempo
che scivola
senza lasciare battito.
Un mostro malinconico,
arruolato dalla pulizia sociale
nella parte del cattivo
che cambia età e storia
ma se gli parlo
scopro che fa parte di me,
anche ora.
I denti aguzzi che digrigna oggi
ieri erano bianche ali d’angeli.
Dixanite
di Vera D’Atri
La dea Kalì appesa nell’armadio,
io non sono niente,
ho dieci mani e non sono niente.
Io sono qui con il detersivo in fiamme,
sbiancata dalla fatica dei miei giorni,
pigra come l’ottone del letto,
piena di cicche, aguzza.
Io sono qui per un mucchio di cose,
qualcuna ogni tanto esplode;
non so come prenderle e ho dieci mani.
Homo Novus
di Ugo Rapezzi
Ha sguardi di radar
informatici lampi
cardioassenti.
Un buco parlante
in faccia strabocca
di bit balbettanti.
L’encefalonulla
si accende agli impulsi
dei videocomandi.
Diteggia senz’arte
con arti ungulati
impoltroniti
e par che sorrida
connesso al segnale
del network sociale.
Carrozza 17
di Silvio Perfetti
Smemorato e confuso
Vago pel bosco
Ansimando all’odore
Del faggio e del muschio
Ma non posso restare
A guardare morire
Chi con le mie mani
Ho dovuto annegare
Sto scappando, lo so
In bocca al destino
Sto scappando, lo so
In bocca ho l’amaro
Smemorato e confuso
Agitando parole
Vane alla mente
Non centrano il cuore
Ma non posso restare
A vedere morire
Chi con le mie mani
Ho dovuto annegare.
Estensioni del Tempo
di Martina Campi
Quando ci troviamo
di fronte
hai in mano il mio
cuore da che gli
hai restituito il
battito e ora dici
che vuoi conoscermi.
Sono come sassi che cadono in uno specchio d’acqua le parole che Martina Campi ti depone addosso con leggerezza, con la delicatezza e l’impalpabile armonia che la contraddistinguono come scrittrice e come interprete della sua poesia accompagnata dalla musica del compositore e polistrumentista Mario Sboarina. E dalla ferita dell’acqua che subito si rimargina inevitabilmente si propagano cerchi infiniti. Sono le associazioni mentali, visive, musicali innescate da queste brevi liriche. A un primo impatto questi versi ti lasciano un po’ incerto sul loro significato e le loro intenzioni ma poi ti accorgi che le immagini che evocano ti rimangono attaccate agli occhi, i pensieri che distillano ti perseguitano e si sviluppano per proprio conto, come “estensioni” non solo del tempo, ma dello spazio, della mente. Con una videocamera appesa al polso Martina si muove attraverso paesaggi familiari offrendo angolazioni sempre nuove: inquadra dall’alto “traiettorie d’angoli e strade e capelli”, scende in picchiata attraverso il “colletto, l’occhio che cade, il mondo per le scale”, esegue un montaggio di dettagli a costruire un ritratto giustapponendo “i piedi nel via vai, le mani al telefono, le bocche briose”. L’obiettivo di Martina è in grado di cogliere e restituirci con parole rivelatrici le percezioni e gli stati d’animo che non sapremmo descrivere, che sgorgano in un attimo, che si trascinano dietro pezzi della nostra vita (lo zucchero mentre fuoriesce / dai barattoli / del mattino, lucidi / perché le mani / ti ricordano / quando hai nuotato / al largo, la prima volta / e poi lo raccontavi) e a volte si dota di un filtro che produce visioni surreali di impressionante potenza (sono tutti questi occhi / come uova appese / assodate, come esche / come ami allacciati / alle ginocchia). Una scrittura densissima, immaginifica e originale che, malgrado la sua ricercatezza e complessità, non suona mai affettata, arrogante o vuotamente virtuosistica. La poesia di Martina è assolutamente sincera, rispecchia la sua acuta e particolare sensibilità, gli occhi che ci presta per riscoprire la realtà, ammantandola di significato, di bellezza, di musica.
Estensioni del Tempo
Martina Campi
Le Voci della Luna, 2012