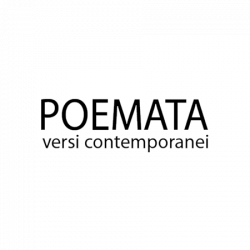Editoriale
di Francesca Del Moro
Già nel momento della nascita sperimentiamo un violento distacco dall’acqua e un grido di pianto si accompagna al primo respiro che ci apre i polmoni. Per tutta la vita serbiamo l’inconscio desiderio di far ritorno al grembo materno, una sensazione che affiora chiaramente nel momento in cui, come “pesci fuor d’acqua”, avvertiamo con sofferenza un senso di estraneità rispetto all’ambiente che ci circonda, alle relazioni che viviamo, perfino a noi stessi. Alessandro Vettori calma il tormento della non appartenenza a una città ostile deponendo il proprio corpo, nudo e quindi sincero e indifeso, accanto alla persona amata. Veronica Liga si sente mancare l’aria ma avverte anche un impulso ad agire di fronte alla pochezza in cui vede finire perfino le cose che sembravano sacre. Ogni speranza si perde nei versi di Vera D’Atri, che fotografano una natura crudele in cui il pesce vive da preda costantemente in fuga e si offre quale metafora dell’essere umano che nel cielo a cui anela trova l’amplificarsi della violenza già conosciuta. La stessa violenza che Martina Campi scopre e al tempo stesso rigetta quale legge naturale, nel momento in cui posa uno sguardo partecipe sull’occhio sbarrato del pesce che rifiuta di vedere come cibo. Infine, con un gioco di specchi Giada Marin allontana sé da sé stessa, usando la seconda e la terza persona, fino a portare al culmine quell’esperienza di alienazione che coincide con il “Non io” di beckettiana memoria.
Sprechi non tanto pubblici
di Veronica Liga
La Madonna abortisce,
Shiva esce dalla discoteca, stordito e barcollante,
Bistecche di Pegaso vanno a male in un frigo da quattro soldi,
Sfere di cristallo buttate nel vetro con bottiglie rotte,
E io che scrivo queste robe
Anziché… anziché!
Sarà la distanza dei miei occhi
di Alessandro Vettori
Sarà la distanza dei miei occhi
il pallore di questa luna che mi cammina addosso
mentre t’appoggio accanto
l’estrema nudità che mi appartiene
come fosse una confessione di squilibrio
una dichiarazione di quanto io m’avvicini alla follia
di non appartenere a questa città ingorda
che ogni giorno mi divora.
Specchio
di Giada Marin
Hai visto la vita sfuggirle di mano
assassinando quella che era
e reputare il mondo un estraneo.
L’ hai vista contare i granelli di sabbia
della clessidra di un tempo perduto
che oggi sembra esserle ignoto
ma ha fatto di lei
un tamburo senza rimbombo
nel silenzio che anticipa
l’incipit di una nuova melodia.
L’hai sentita ridere e soccombere
nel medesimo istante
senza appurare mai la sua caduta;
l’hai vista barcollare
nel suo tempo distropico;
l’hai scorta mentre sfasciava la sua ombra
nel buio del viale
e ricomponeva i pezzi di se stessa
con estremo garbo
alla luce dell’aurora.
Deposizioni
di Martina Campi
Si perde un mattino
nella forma postera del sole,
movimento che ha
spostato di un poco la stanza.
Avrei voluto soltanto
raccoglierti e tenerti
con me, ma ti avevano già
staccato la testa
si sono mangiati
persino il nome e poi
si sono lavati le mani
col sapone a resti.
La traccia che vorrebbe
stendersi al passaggio
si attorciglia
al rumore
io non so più dove posare
l’occhio aperto e
per questo ormai
mi sento sazia.
Portiamo
la terra
che non
possediamo
e ti sorridono sempre
anche mentre
li fai a pezzi.
Li hai fatti a pezzi anche tu.
Il gabbiano s’infilza nel mare
di Vera D’Atri
Il gabbiano s’infilza nel mare.
Ha fame.
La fame, quando divora,
a volte ha ali bianche e improvvise
e il pesce si solleverà con esse.
Sorvolerà con occhi tondi e argentei
il dorso raggrinzito del mare sotto al vento,
la cruda indifferenza dei riflessi
e solo allora saprà che il cielo
ha bocche spaventose,
il pesce,
che fuggiva sagome lisce nelle profondità.
La spugna
di Lella De Marchi
Dove mi passa la voce del mondo?
Qual è il punto esatto in cui tutto comincia?
Che cos’è la sostanza delle cose?
Con ciascuno di questi versi si aprono rispettivamente le prime tre poesie di questa bellissima raccolta, interrogativi universali a cui l’autrice non fornirà risposte univoche ma che daranno il via a un’indagine scrupolosa. Un’indagine che riesce a dar voce all’ineffabile presa di coscienza del bambino nel momento in cui per la prima volta scopre i confini tra sé e l’esterno e dice “io”. Ed è infatti scegliendo la prima persona che Lella De Marchi si asporta un pezzo di tessuto e lo pone sotto il microscopio per indagare a fondo la propria composizione in quanto essere umano. Quella che si offre al suo sguardo penetrante e consapevole è una consistenza spugnosa. La spugna presenta due fondamentali caratteristiche: la porosità, che le consente di assorbire i microrganismi di cui si nutre, e la capacità di disgregarsi e riaggregarsi. Da queste caratteristiche si dipartono i due binari che scorrono paralleli lungo tutta la raccolta. Da un lato, infatti, l’io-spugna tende ad assorbire il proprio ambiente, scoprendosi cosa tra le cose, librandosi per farsi aria, serbando in sé il germe materno e la vivezza dei ricordi, perseguendo una fusione totale con l’essere amato. Ma a questa spinta centripeta, come nota opportunamente Renato Martinoni nell’introduzione, corrisponde uno slancio centrifugo che porta l’essere umano a disgregarsi in un’inafferrabile molteplicità, a scoprirsi ingannevole ai propri occhi e a quelli altrui, arrivando addirittura a riconoscersi nel nulla, acme della disgregazione che precede la riaggregazione. Curatissime sul piano del ritmo, queste liriche compongono una sinfonia di illuminazioni che si imprime a fondo nella mente del lettore sposando la poesia alla metafisica.